
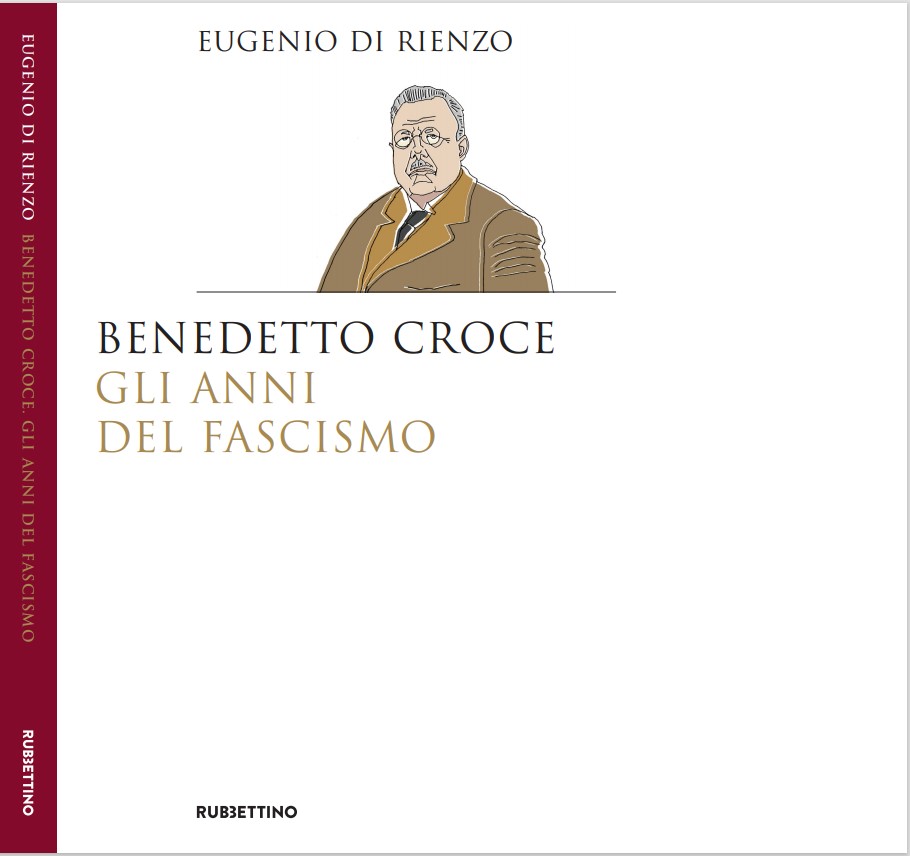
di Luca Micheletta
Scrivere un libro su D’Annunzio a Fiume non è cosa facile, dato che il personaggio e l’impresa di Fiume sono stati oggetto di una copiosissima storiografia, che ha già indagato le tante sfaccettature che l’impresa fiumana ha avuto, ma anche il suo significato per la storia d’Italia come incubatrice di modelli ed esperienze che avrebbero poi trovato, in qualche forma, una replica nella marcia su Roma e nel fascismo. Eugenio Di Rienzo, nel suo D’Annunzio diplomatico e l’impresa di Fiume (Rubbettino Editore) ha seguito una nuova pista, quella del D’Annunzio diplomatico, appunto, approfondendo, sulla base di una ricca documentazione, non solo i rapporti del poeta con gli ambienti romani, nel tentativo di comporre la crisi aperta tra l’entità fiumana e il governo centrale, ma anche allargando lo sguardo per cogliere i più ampi risvolti internazionali che l’impresa fiumana ha avuto, nel tentativo di proporsi come centro propulsivo di una contestazione anti-sistemica a livello globale. Nel D’Annunzio diplomatico, infatti, Di Rienzo dimostra come lo scrittore tentò di ergersi ad architetto di una grande rivoluzione contro il nuovo ordine mondiale che si stava costituendo come conseguenza della fine della prima guerra mondiale, un nuovo ordine deciso e imposto alla conferenza della pace di Parigi dalle grandi potenze democratiche occidentali (Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia). Contro questo nuovo ordine mondiale, D’Annunzio chiamò a raccolta tutti gli insoddisfatti della sistemazione di pace: dai popoli sconfitti, come austriaci, turchi e ungheresi, ai popoli che attendevano impazienti di affrancarsi dal colonialismo imperialista degli anglo-francesi, come gli egiziani, gli indiani, gli irlandesi, spingendosi anche a immaginare, in funzione antistatunitense, una partecipazione degli afro-americani. Per D’Annunzio, secondo l’autore, Fiume doveva divenire la scintilla per appiccare un grande incendio mondiale, una rivoluzione contro l’ordine di Versailles, contro coloro che ancora dominavano coi loro imperi larga parte del mondo africano e asiatico.
Particolarmente suggestiva, sotto questo aspetto, è la ricostruzione che l’autore fa delle origini e dell’attività della Lega dei Popoli, che D’Annunzio, e in particolare alcuni suoi collaboratori, come Kochnitzky, cercarono di costituire come organizzazione anti-Versailles, anti-Società delle Nazioni, al fine di operare congiuntamente contro le decisioni della conferenza della pace e contro il trattato di pace con la Germania firmato a Versailles, che aveva nel suo preambolo lo Statuto della Società. Un trattato che, per le modalità con cui è stato negoziato (i vinti non presero parte alla conferenza della pace, fatto senza precedenti nella storia europea degli ultimi secoli) e imposto ai tedeschi (con un ultimatum), era ormai assurto a simbolo di una pace ingiusta e vendicativa, frutto di egoismo, prepotenza, arroganza. Programma di rigenerazione radicale della comunità internazionale alternativo a quello wilsoniano di Società delle Nazioni, che pure aspirava alla rifondazione del sistema internazionale, la Lega dei Popoli dannunziana si proponeva una vera e propria rivoluzione contro i vincitori, contro le “plutocrazie”, contro, insomma, il mondo capitalista anglo-sassone e quello che oggi potremmo definire l’ordine liberale. Non a caso emerge bene dallo studio di Di Rienzo l’attenzione che a Fiume si prestò alla rivoluzione bolscevica e al fenomeno del bolscevismo in generale, non certo come adesione all’ideologia marxista-leninista, almeno non in D’Annunzio, quanto a quel disegno di radicale palingenesi dell’umanità e della comunità internazionale che il bolscevismo stava abbozzando. Appare chiaro che la rivoluzione bolscevica e quella che si propone la Lega dei Popoli hanno un comune nemico da battere nell’Occidente che si sta consolidando, sia in termini di assetto-politico territoriale, sia in termini di dominanza finanziaria anglo-americana.
Il progetto della Lega dei Popoli è certamente del tutto velleitario e pieno di contraddizioni per varie ragioni, che l’autore non manca di rilevare. La prima è che non ha finalità chiare oltre a quella di una generica rivoluzione anti-Versailles; e infatti non si comprende come la Lega dei Popoli si proponeva di dirimere le aspirazioni contrastanti degli stessi popoli che chiamava a raccolta. Come sostenere i croati nella loro lotta contro il centralismo serbo, ma poi privarli dell’Istria? Come sostenere gli ungheresi e poi privarli della Croazia o di Fiume? Come conciliare le aspirazioni dei giapponesi sul suolo cinese con l’appello alla riscossa dei cinesi stessi? Come conciliare le rivendicazioni italiane al controllo sull’Albania o alla sovranità su Valona con l’idea dell’indipendenza degli albanesi? Sono quesiti che rimangono senza risposta e che fanno pensare a un progetto che termina con l’appello alla rivoluzione ed è fine a sé stesso. Un progetto che non ha radici filosofiche, ideologiche, come le ha la rivoluzione bolscevica, che possano esprimere, oltre la rivoluzione, una coerente proposta politica di una nuova società umana e internazionale. D’altra parte, nemmeno a Fiume si edifica una società nuova che possa servire da modello; la reggenza è un laboratorio di suggestioni e di idee incompiute o realizzate solo sulla carta. E l’autore lo spiega bene, perché, seppure neghi che D’Annunzio possa essere considerato il progenitore del fascismo, ci avverte che non è nemmeno ispirato da quegli ideali democratico-socialisti contenuti nella Carta del Carnaro, concepita da un sindacalista rivoluzionario come Alceste De Ambris, ma che nei fatti non fu mai applicata come costituzione e fu semplicemente un “castello di carta”.
La seconda ragione per cui il progetto di Lega dei popoli risulta contradditorio è che D’Annunzio vuole inserire all’interno della sua cornice anche l’Italia, che però è una potenza vincitrice, ha un modello sociale ed economico di tipo capitalista e pure istituzioni democratiche, per quanto imperfette e forse non più adeguate al mutamento della società italiana; ed è un’Italia che siede tra quei pochi “grandi” della terra che a Parigi decidono quell’assetto politico-territoriale che D’Annunzio vuole denunciare e anzi rivoluzionare. Secondo il poeta, l’Italia avrebbe dovuto militare tra i rivoluzionari della Lega in ragione della vittoria mutilata, di cui la negazione della sovranità su Fiume alla conferenza della pace appariva essere il simbolo. Che però, per quanto l’eccitazione nazionalista avesse presa sull’opinione pubblica italiana e la questione di Fiume fosse sentita, era un po’ poco per entrare nel club dei rivoluzionari. Anche questa è un’altra contraddizione irrisolvibile e infatti il progetto della Lega dei Popoli, ci spiega Di Rienzo, venne accantonato dallo stesso D’Annunzio a partire dal 1920 e rimase solo come cornice, forse inutile, di un progetto di ribellione ai dettami della conferenza di Parigi solo per quanto riguardava l’Italia, la sua sistemazione confinaria e i suoi interessi nazionali, adriatici e mediterranei. Kochnitzky, che ne era stato l’ispiratore, si dimise nel luglio 1920, quando comprese che la Lega era divenuta funzionale solo ai disegni dell’Italia, un “utensile ad uso balcanico”; una Lega che finirà sotto la guida di Coselschi, uomo vicino a Mussolini e che le darà un’impronta sciovinista e conservatrice.
Contraddizioni e velleità, dunque, che caratterizzano il disegno politico di D’Annunzio per Fiume, per l’Italia e per il mondo e che aprono alla domanda sul reale valore del poeta come politico e diplomatico. La mia impressione, dopo la lettura del bel volume di Di Rienzo, è che D’Annunzio non è e non si propone come uomo di potere o di governo, non è uno statista o un diplomatico, ma rimane un poeta, uno scrittore che coltiva il mito del superuomo, un uomo d’avventura che si nutre di passioni, anche della passione politica, ma che in fondo disprezza il potere e la politica come istituzione e si agita come un tardoromantico sognatore. Sono questi limiti che, a mio avviso, trasformano D’Annunzio, mi pare inconsapevolmente, in uno strumento del potere e della politica, uno strumento che viene utilizzato, finché fa comodo, da quei “poteri forti”, come li chiama l’autore, che, coralmente, sostengono in ogni modo l’impresa fiumana per conseguire il banale interesse nazionale di assicurare Fiume all’Italia con un fatto compiuto come l’occupazione di D’Annunzio, nel momento in cui appare certo che Fiume sta per essere perduta.
Che l’impresa fiumana fosse in qualche modo pilotata da Roma lo avevo potuto constatare anche io quando avevo studiato la politica estera italiana alla conferenza della pace e ne avevo registrato l’assoluta corrispondenza di finalità e di tempistica. Il libro di Di Rienzo approfondisce molto bene questo aspetto e indaga approfonditamente su chi erano coloro i quali sostenevano la marcia di Ronchi e quali erano le loro motivazioni. Più importante di tutti, il partito militare, cresciuto a dismisura durante la guerra e con non poche tentazioni golpiste al suo interno da parte di generali che rinfacciavano le difficoltà italiane (soprattutto dopo Caporetto) ai politici e alla frammentazione del quadro politico parlamentare. Non diversamente da quanto spesso avviene durante e dopo le guerre e da quanto è avvenuto in altri paesi dopo la prima guerra mondiale, come ad esempio in Germania, dove sappiamo bene che forza ha avuto il partito militare e la sua leggenda sulle responsabilità della politica nella sconfitta, prima e dopo la nascita della Repubblica di Weimar. Che il partito militare sia fondamentale lo si vede bene nel libro di Di Rienzo dal fatto che il protagonista più importante dell’impresa fiumana dopo D’Annunzio, o forse direi al pari di D’Annunzio, è Pietro Badoglio, commissario straordinario militare per la Venezia Giulia, che opera per avere Fiume, prima cercando di cancellare dalla carta politica europea il principale oppositore ai disegni territoriali italiani, il Regno Serbo-Croato- Sloveno, con il sostegno alle forze centrifughe nazionalistiche, che si oppongono alla creazione di uno stato sotto l’egemonia serba, e poi appoggiando la marcia di Ronchi. E Badoglio è non solo un militare, ma un piemontese, nominato senatore del Regno nel febbraio 1919, cioè è un uomo intimo del re, che proprio come dimostra Di Rienzo è anch’egli complice di D’Annunzio. Un re che fu certamente d’accordo alla marcia su Fiume e dette il suo assenso, anche se tra molte preoccupazioni che l’esercito si insubordinasse e finisse per sfuggirgli di mano il comando, che pure aveva per diritto statutario.
Accanto a militari e al re, si muovono in favore dell’impresa fiumana la massoneria, con le sue vaste ramificazioni nella società italiana dell’epoca; il complesso finanziario-industriale, che elargisce copiosi finanziamenti a D’Annunzio; lo stesso ministro degli Esteri Tittoni, che è un giolittiano, ma che condivide l’accondiscendenza all’impresa di Fiume con i vertici della diplomazia, come Contarini, che è segretario generale della Consulta, o Sforza, sottosegretario agli Esteri e futuro ministro. E, infine, lo stesso Nitti, che critica apertamente l’impresa fiumana, anzi la condanna, ma che non volle mai realmente utilizzare la forza contro D’Annunzio, benché ciò fosse possibile e, almeno all’inizio dell’avventura dannunziana, anche dal punto di vista militare realizzabile con relativa semplicità.
Di Rienzo dà un giudizio molto severo su Nitti, di cui critica fortemente alcuni passaggi della sua azione politica condotti con mentalità “ragionieresca”, certo per la necessità di risanamento dei conti pubblici, ma senza adeguata ponderazione, come la smobilitazione rapida e massiccia con cui furono liquidati 1 milione e settecentomila uomini sotto le armi, un esercito che rimase senza lavoro (molti reduci già dalla guerra di Libia), spesso senza arte né parte, e che andò a gonfiare il partito militare. Ammetto che anche io quando ho studiato Nitti non ne ho ricevuto un’impressione immediatamente positiva. Leggere la sua corrispondenza, con il suo tono sempre perennemente in allarme per qualche minaccia o qualche rischio, zeppo di tirate moralistiche verso i destinatari, non lo rende simpatico e certo non lo accomuna minimamente allo stile asciutto e pragmatico di Giolitti, che è il suo padrino politico e che metterà fine alla esperienza fiumana. Nitti, tuttavia, opera in una situazione davvero eccezionale, come spesso lo è un dopoguerra e, da studioso e professore di economia, comprende che il mondo si sta trasformando proprio sotto quella dominanza finanziaria anglo-americana, che D’Annunzio vuole superficialmente e contraddittoriamente sovvertire. Insomma, se, come scrive l’autore, la prospettiva con cui D’Annunzio guarda al mondo futuro è quella euro-asiatica e all’interno di questa prospettiva vorrebbe collocare l’Italia, quella di Nitti è quella dell’Occidente, dove Cavour ha posto l’Italia nel 1861 e dove avrebbe dovuto rimanere per scelta e per necessità. È questa, mi pare, la domanda fondamentale che, in definitiva, impone il giudizio su D’Annunzio diplomatico dopo la lettura delle mille pagine che segnano l’ultima fatica di Di Rienzo. E ci si potrebbe chiedere ancora se, nonostante l’indubbia abilità che dimostra D’Annunzio nell’ordire oltre che nell’ardire, e che ben mette in risalto il volume, l’impresa fiumana fu, per citare un altro poeta, vera gloria di D’Annunzio, oppure più prosaicamente l’esecuzione di una commedia che quei “poteri forti”, che ha così finemente individuato l’autore, e non D’Annunzio, avevano scritto per lui.
(Pubblicato in © «Studi Politici», 2, 2023)
