di Marco Gervasoni
Chi controlla il tempo controlla il potere. Non solo chi è in grado di determinare il tempo degli altri, ma anche chi riesce a spiegare come il tempo scorra e dove ci stia portando, possiede il potere (o almeno una sua parte). E vale naturalmente l’inverso: chi riesce a prendere il potere, vi resterà tanto più quanto saprà imporre la propria idea di tempo. E la propria idea di storia. Un tema assai affascinante, lanciato qualche anno fa dallo storico tedesco Reinhardt Koselleck e più di recente da quello francese François Hartog, con la nozione di «regimi di storicità». Da questi due numi titolari della storiografia degli ultimi decenni parte Christopher Clark, in un libro da leggere per almeno tre ragioni: Time and Power. Visions of History in German Politics from the Thirty Years’s War to the Third Reich, Princeton University Press (293 pp., € 27,00). Per il repertorio di conoscenze che trasmette. Per il profilo dell’autore, Per quanto ci svela sulla Germania di oggi e quindi sull’Europa.
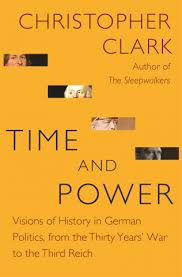 Prima ragione. Si tratta di un lavoro originalissimo, in cui l’autore mostra come quattro capi appartenenti a epoche diverse della storia tedesca abbiano impresso la loro idea di tempo e di storia, determinante per l’edificazione del loro potere. Il Grande Elettore di Brandeburgo, Federico Guglielmo, nel XVII secolo, impone una idea di tempo in cui la sovranità dello Stato prussiano, di cui egli pone le premesse, irrompe nel racconto della storia europea. Il suo successore, Federico II di Prussia detto il Grande, nel XVIII secolo, per altro eccellente storico di suo, afferma un’idea di tempo ciclica in cui la vittoria della ragione e della Prussia tendono a coincidere. Saltiamo un secolo, ed ecco un altro prussiano, Bismarck, fondatore della Germania, in cui l’idea di tempo coincide con l’egemonia tedesca ma intesa come forza equilibrante nel consesso europeo. E infine ecco il regime di storicità imposto da Hitler, nel XX secolo: una storia senza storia. Nella concezione razziale dei nazisti prevale infatti la visione di tempo millenaristica, dove la storia come sviluppo, anche della nazione, è cancellata: per questo è una bestialità dire che il nazismo fu l’apotesi del nazionalismo.
Prima ragione. Si tratta di un lavoro originalissimo, in cui l’autore mostra come quattro capi appartenenti a epoche diverse della storia tedesca abbiano impresso la loro idea di tempo e di storia, determinante per l’edificazione del loro potere. Il Grande Elettore di Brandeburgo, Federico Guglielmo, nel XVII secolo, impone una idea di tempo in cui la sovranità dello Stato prussiano, di cui egli pone le premesse, irrompe nel racconto della storia europea. Il suo successore, Federico II di Prussia detto il Grande, nel XVIII secolo, per altro eccellente storico di suo, afferma un’idea di tempo ciclica in cui la vittoria della ragione e della Prussia tendono a coincidere. Saltiamo un secolo, ed ecco un altro prussiano, Bismarck, fondatore della Germania, in cui l’idea di tempo coincide con l’egemonia tedesca ma intesa come forza equilibrante nel consesso europeo. E infine ecco il regime di storicità imposto da Hitler, nel XX secolo: una storia senza storia. Nella concezione razziale dei nazisti prevale infatti la visione di tempo millenaristica, dove la storia come sviluppo, anche della nazione, è cancellata: per questo è una bestialità dire che il nazismo fu l’apotesi del nazionalismo.
Affascinante, ma bisogna essere storici con i galloni per muoversi su questi piani senza scivolare. Clark lo è, uno dei massimi esperti anglosassoni della storia tedesca: australiano trapiantato a Oxford, autore di libri importanti sulla Germania tra XVIII e XX secolo. Autore soprattutto di un volume continuamente citato da Angela Merkel, I sonnambuli, una storia della prima guerra mondiale. I maligni dicono che sia lo storico preferito da Merkel perché attenua la colpa di Berlino nella carneficina del 1914. In realtà Clark è amato dalla Cancelliera perché in tutta la sua produzione ci restituisce una visione della Germania come forza egemonica, magari un po’ brutale e rigida, ma tutto sommato gentile. E indispensabile all’Europa. L’Europa avanza, sembra dirci Clark, quando l’egemonia tedesca è chiara e definita, soprattutto nella testa di chi sta a Berlino.
Ecco la terza ragione per cui i leggere i suoi libro e soprattutto l’ultimo. La Germania (ri)unita, dopo il 1989, sta imponendo, e questa volta non più solo a se stessa, un nuovo regime di storicità in cui l’integrazione europea è la fine della storia. Come ben sapevano i francesi sconfitti a Sedan nel 1870, la Grande Germania è un problema non solo geopolitico ma filosofico. Ed è tornata ad esserlo dopo il 1989. Quando Andreotti celiava «amo talmente la Germania da volerne due» o Margaret Thatcher metteva in guardia dal ritorno di una potenza, sia pure solo economica, nella heartland, molti li trattarono da anziani rimbambiti. Ma in realtà possedevano una saggia visione della storia, quindi plurisecolare. In cui la Germania è stata sì fautrice di equilibrio nel consesso europeo ma al tempo stesso ha sempre posto le premesse per il suo disfacimento. E anche se Clark è lo storico preferito da Merkel, qualche inquietudine percorre le pagine finali del libro, in cui si respira il senso di una crisi della UE: che potrebbe essere terminale.
(Pubblicato il 17 febbraio 2019 © «il Messaggero»)
