di Luigi Vicinanza
Viviamo in un presente senza storia. La vita pubblica si consuma tra un sondaggio e una diretta Facebook. Si invocano identità culturali ed etno-geografiche con la sistematica strumentalizzazione di un passato sconosciuto e immaginario. Prigionieri di una bolla retorica. Eppure proprio in questa delicata fase storica ci sarebbe più che mai bisogno di conoscere chi siamo stati per provare a comprendere chi siamo. “Tutto è storia, la vita è storia, la storia è vita, e, solo se così considerata, il suo valore è elevatissimo” insegna Aurelio Musi, autorevole maestro nel panorama scientifico nazionale e internazionale.
A lui — noto ai lettori di questo giornale come firma prestigiosa e penna acuminata — è dedicato un raffinato volume curato da Giuseppe Cirillo e Maria Anna Noto: “Ragioni e stagioni della storia. Le vie della ricerca di Aurelio Musi” (Rubbettino editore con l’Università di Salerno, 326 pagine, € 19,00). Negli atenei si usa, a conclusione della carriera accademica, fare omaggio di una pubblicazione al proprio maestro: 39 autori ripercorrono l’attività ultraquarantennale di Musi, dal 1976 al 2019, rivisitando la sua preziosa produzione di libri di divulgazione e testi accademici. Ne emerge una figura di studioso a tutto tondo impegnato nella ricerca scientifica, nella promozione della cultura, dedito all’insegnamento e impegnato nel giornalismo con le analisi politiche sull’attualità. “Storico pensante” lo definisce Giuseppe Cacciatore, perché Musi riesce a tenere insieme quella “relazione circolare tra storia pensata, storia narrata e storia vissuta”.
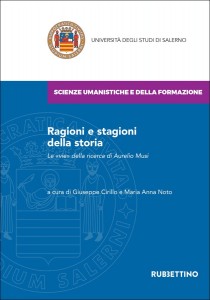 Musi, allievo prima e poi amico di Giuseppe Galasso, ha studiato in profondità la Napoli spagnola nei secoli XVI e XVII; a lui è attribuibile una lettura alternativa di quel periodo. Un’epoca “non più schiacciata sul paradigma della decadenza, ma letto nella sua complessità come fase in cui la comprensione delle vicende italiane appare inscindibilmente connessa al funzionamento della macchina imperiale spagnola e alla sua politica di potenza”, sottolinea Ilaria Zilli. Una Napoli europea, bene ricordarlo, parte di un impero ma con una sua autonoma organizzazione statuale. Ancora nel suo libro più recente, Masaniello. Il masaniellismo e la degradazione di un mito, pubblicato appena poco prima che l’Italia si bloccasse per effetto della pandemia, torna agli anni della dominazione spagnola su Napoli e sul Mezzogiorno d’Italia, tanto da far dire a Carmine Pinto che “il mistero di Masaniello accompagna l’opera storiografica di Aurelio Musi”. Si capisce il perché di questa rigorosa attenzione. Il pescivendolo di piazza Mercato, il capopopolo della rivolta del 1647 si rivela “una personalità di confine tra i ceti, in una capitale affollata, popolata da un’aristocrazia aggressiva e potente, da gruppi in movimento nelle professioni e negli apparati reali, da una plebe numerosa, ignorante e vivace”. Sembra di viverle queste vicende, non sono così lontane nel tempo.
Musi, allievo prima e poi amico di Giuseppe Galasso, ha studiato in profondità la Napoli spagnola nei secoli XVI e XVII; a lui è attribuibile una lettura alternativa di quel periodo. Un’epoca “non più schiacciata sul paradigma della decadenza, ma letto nella sua complessità come fase in cui la comprensione delle vicende italiane appare inscindibilmente connessa al funzionamento della macchina imperiale spagnola e alla sua politica di potenza”, sottolinea Ilaria Zilli. Una Napoli europea, bene ricordarlo, parte di un impero ma con una sua autonoma organizzazione statuale. Ancora nel suo libro più recente, Masaniello. Il masaniellismo e la degradazione di un mito, pubblicato appena poco prima che l’Italia si bloccasse per effetto della pandemia, torna agli anni della dominazione spagnola su Napoli e sul Mezzogiorno d’Italia, tanto da far dire a Carmine Pinto che “il mistero di Masaniello accompagna l’opera storiografica di Aurelio Musi”. Si capisce il perché di questa rigorosa attenzione. Il pescivendolo di piazza Mercato, il capopopolo della rivolta del 1647 si rivela “una personalità di confine tra i ceti, in una capitale affollata, popolata da un’aristocrazia aggressiva e potente, da gruppi in movimento nelle professioni e negli apparati reali, da una plebe numerosa, ignorante e vivace”. Sembra di viverle queste vicende, non sono così lontane nel tempo.
Infatti Musi le fa dialogare con le avventure politiche di sindaci partenopei come Achille Lauro o Luigi de Magistris, persino con fenomeni recenti alla base dei successi dei populismi europei e internazionali. La cronaca che si fa storia è oggetto della continua ricerca dello ” storico pensante”. Marco Trotta si sofferma su un saggio del 2004, “La stagione dei sindaci”, scritto dieci anni dopo la riforma dell’elezione diretta dei primi cittadini. Bassolino a Napoli e De Luca a Salerno furono i due simboli di “quel ciclo che diede origine a una vera e propria rivoluzione dei sistemi politici urbani e dei compiti di amministratori pubblici protagonisti rinnovati di un’Italia che stava allora fuoriuscendo dalle macerie della Prima Repubblica”.
La “stagione dei sindaci” è conclusa da tempo. Forse, anche alla luce dei risultati delle recenti regionali con l’eccezionale quantità di voti incassati da Zaia in Veneto e da De Luca in Campania, non è da escludere un prossimo lavoro di Musi sull’accentuata, quanto imprevedibile fino a qualche tempo fa, personalizzazione del “partito dei governatori”.
Già, ma qual è il metodo di ricerca storica applicato da Musi? Quali le vie da percorrere? La parola “vie” appare nel sottotitolo del volume e, secondo i curatori, evoca percorsi, processi, incroci, ramificazioni direzioni, orientamenti, “tutti elementi fondanti della storia”. Così una delle vie imboccate ci porta diritto sul lettino del padre della psicanalisi. “In Freud e la storia Musi approfondisce ed estende la sua critica dello storicismo attraverso le scoperte dello psicanalista viennese sulle potenze primordiali, spaesanti. .. che dimorano nel cuore dell’umano”, annota Mauro Nelson Maldonato.
I problemi storiografici e le “vie” per esplorarli si intrecciano nel corso degli anni. L’idea di ” Nazione napoletana” — un tema caldo ancor oggi — viene analizzata nei tre interventi di Giuseppe Cirillo, di Antonino Di Francesco e di Eugenio Di Rienzo. Emerge come Musi si adoperi per sottrarre la questione napoletana a un’astiosa recriminazione sudista e alla vivace propaganda neoborbonica, fondata su dati inconsistenti. Ma qual è allora la nostra vera identità nazionale? Confrontandosi con il pensiero di Gramsci, di Croce, di Gobetti, si delinea in un suo recente lavoro una “storia della coscienza che gli italiani hanno avuto delle ragioni di una loro esistenza comune, che ha convissuto con il farsi concreto di uno spazio italiano, di una nazione italiana”, osserva Luigi Mascilli Migliorini. Un Paese unito nella sua diversità, insomma, niente affatto anomalo rispetto ad altri stati europei. Con buona pace di chi è immerso in una perenne campagna elettorale e tenta di illudere una nazione abusando in tv e sul web di facili slogan.
(Pubblicato il 7 ottobre 2020 © «la Repubblica» – News)
