di Ermanno Bencivenga
Una delle cose che ho sempre rimproverato alla mia educazione liceale, peraltro ottima, è che se ne usciva con un’illusione di completezza: avendo «fatto» la storia, e anche la storia della filosofia, dell’arte e di varie letterature, si presumeva di avere il «quadro» della situazione, l’«idea generale» di tutto; quindi si poteva passare a occuparsi d’altro (di banche, di processi, di aziende…). In realtà non era così: di queste storie si sapeva ben poco. Ma si era appreso un linguaggio: quello che circolava tra la maledetta «classe dirigente» e permetteva a chi lo parlasse di ammiccare con aria d’intesa se nel discorso venivano fuori la battaglia di Lepanto, la dialettica hegeliana o i ritratti di Rembrandt. Poi magari questa stessa persona non avrebbe riconosciuto un Rembrandt in un museo, non sapeva dove fosse esattamente Lepanto o riduceva la dialettica hegeliana alla stanca e fallace formula tesi/antitesi/sintesi; ma in gioco non era comunque cultura, era una batteria di riferimenti con cui identificare i propri pari ed escludere gli ignoranti del Nuovo o Nuovissimo Mondo i quali di Lepanto non conoscevano il nome.
Con il tempo, la natura eurocentrica di quei riferimenti è stata messa in discussione, il mondo si è globalizzato ed è divenuto di moda evocare nomi e luoghi più esotici. Ci si è resi conto insomma che anche altri continenti avevano una loro storia, e arte e filosofia e letteratura; si è criticato il «canone»; se ne sono costruite versioni più accoglienti. È in quest’ottica che vedo inserita la Storia del mondo dall’anno 1000 ai giorni nostri di Francesca Canale Cama, Amedeo Feniello e Luigi Mascilli Migliorini, professori alle Università della Campania, dell’Aquila e L’Orientale di Napoli. Un libro per certi versi enorme, di oltre milletrecento pagine, ma del tutto proporzionato se visto come manuale per un liceo. Copre, infatti, più o meno, gli ultimi tre anni del programma di storia, in modo corposo ma non fuori misura.
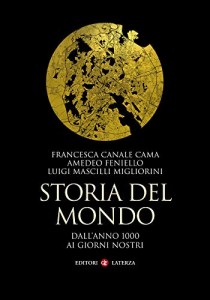 La pubblicità editoriale vorrebbe convincerci che il libro «mostra i fili e i legami nascosti che uniscono la storia degli uomini sulla terra» e «la costante interconnessione che ci appare erroneamente come la grande novità del solo nostro tempo». In realtà, di Marco Polo e della Via della seta si parlava anche nel mio manuale, mezzo secolo fa, e fili e legami qui non hanno un’evidenza molto maggiore. Il capitolo sulla Rivoluzione francese, per dirne una (che comprende anche Napoleone e arriva fino al Congresso di Vienna), è un resoconto chiaro e conciso (una ventina di pagine) di quanto avvenne allora in Europa, che avrebbe potuto figurare, senza variazioni, in un qualsiasi manuale tradizionale, e lo stesso vale per il capitolo che si occupa del passaggio dal feudalesimo ai comuni, o per quello sulla Grande guerra. (In tema di fili e legami, sarebbe stato carino spendere due parole sull’episodio narrato da Peter Weir in Gallipoli, quando nel 1915 soldati australiani si trovarono a combattere in Turchia. Nel film la storia è un po’ romanzata, ma l’insensatezza «globale» dell’evento è significativa.)
La pubblicità editoriale vorrebbe convincerci che il libro «mostra i fili e i legami nascosti che uniscono la storia degli uomini sulla terra» e «la costante interconnessione che ci appare erroneamente come la grande novità del solo nostro tempo». In realtà, di Marco Polo e della Via della seta si parlava anche nel mio manuale, mezzo secolo fa, e fili e legami qui non hanno un’evidenza molto maggiore. Il capitolo sulla Rivoluzione francese, per dirne una (che comprende anche Napoleone e arriva fino al Congresso di Vienna), è un resoconto chiaro e conciso (una ventina di pagine) di quanto avvenne allora in Europa, che avrebbe potuto figurare, senza variazioni, in un qualsiasi manuale tradizionale, e lo stesso vale per il capitolo che si occupa del passaggio dal feudalesimo ai comuni, o per quello sulla Grande guerra. (In tema di fili e legami, sarebbe stato carino spendere due parole sull’episodio narrato da Peter Weir in Gallipoli, quando nel 1915 soldati australiani si trovarono a combattere in Turchia. Nel film la storia è un po’ romanzata, ma l’insensatezza «globale» dell’evento è significativa.)
Quel che c’è di meno tradizionale, in questo libro, è il fatto che il capitolo sulla Rivoluzione francese sia seguito da un altro sulla Rivoluzione americana e sulle guerre di liberazione nell’America latina, e da un altro sull’Africa, entrambi pure di una ventina di pagine; che di Africa si parli anche indipendentemente dalla colonizzazione europea (iniziando con un lodevole «Troppo a lungo quella africana è stata considerata una storia che non esiste. Si sono accumulati stereotipi e pregiudizi»); che l’America venga raccontata anche prima della sua «scoperta». L’Europa, ivi incluse le sue politiche imperialiste, occupa un migliaio delle pagine complessive; ma le aperture al diverso sono certo da apprezzare.
Eppure la mia perplessità rimane la medesima che accompagnò la mia educazione liceale. Come si sconfigge l’autoreferenzialità di una finta cultura che si bea dell’illusoria completezza della sua conoscenza? Come vi si introduce il sospetto che esistano metodologie e punti di vista totalmente alieni, non assimilabili al suo sguardo d’aquila? Informandola dell’esistenza di un regno del Congo creato a metà del XIV secolo, della presenza tolteca nello Yucatan fra il 1000 e il 1200 o del regno cambogiano di Angkor (a partire dal IX secolo)? Ne dubito. È «la storia» come narrazione unitaria che deve terminare: frantumarsi in storie solo rizomaticamente connesse, in prospettive non riconducibili sotto un singolo tetto. Se questo è, a tutti gli effetti, un manuale, aspetto di vederne un altro che si accontenti di aprire qualche squarcio in tali prospettive, che sappia guardare da lì e si fermi quando le sue capacità empatiche si sono esaurite, lasciandoci il senso che c’è ancora un mondo di cose che non sappiamo.
(Pubblicato il 15 dicembre 2019 © «il Sole 24 Ore»)
