di R.J.B. Bosworth
Dal decennio scorso Eugenio Di Rienzo ha diretto un periodico italiano consacrato dal tempo, la Nuova Rivista Storica. Si è specializzato in quelle esplorazioni “realistiche” della politica estera dello stesso genere diffuso nella storiografia anglosassone prima degli anni Settanta, ma oggi meno consueto. Con il collega Emilio Gin nel 2013 ha pubblicato Le potenze dell’Asse e l’Unione Sovietica 1939-1945, uno studio sui rapporti tra le potenze dell’Asse (Germania nazista, Giappone imperiale e Italia fascista) e l’Unione Sovietica. Né l’ideologia né lo sterminio di massa di ebrei e “slavi” erano considerati come la spinta dei frequenti rapporti tra i quattro paesi, che scaturivano invece dalla Realpolitik. Di Rienzo è stato inoltre un recensore caustico e combattivo; per questo potrebbe essere davvero quello che A.J.P. Taylor chiamava “scherzo” il fatto che il suo ultimo libro sia dedicato al suo gatto scomparso Toto, ricordato come una “creatura dolce, paziente e affabile”.
In questo nuovo studio, Di Rienzo mantiene la propria fede nella Realpolitik, anche se la forma biografica aggiunge un contesto umano al quale nel lavoro precedente non era assegnato molto spazio. Mettendo in dubbio la tesi diffusa secondo la quale “fascismo [la f minuscola implica dei luoghi al di là dell’Italia] significa guerra”. Di Rienzo sollecita una notevole revisione della posizione degli studiosi stranieri della politica estera italiana come Macgregor Knox e Robert Mallett, i quali hanno visto Mussolini fortemente determinato all’aggressione revisionista fin dal 1919. Al contrario, le relazioni internazionali della dittatura sono ritratte più come dovute alle tradizioni dell’”ultima delle Grandi Potenze”, mai abbastanza potente per agire per proprio conto, ma sempre in cerca dell’opportunità per diminuire il divario con gli imperi europei più consolidati.
A differenza di molti storici accademici italiani, Di Rienzo scrive in maniera brillante. Galeazzo Ciano, nel giugno 1936 promosso da Mussolini (che era il padre di sua moglie) a più giovane ministro degli Esteri d’Europa (e contemporaneamente vicesegretario del Partito fascista), ci dice in maniera perspicace l’autore, era un “vero credente”. Era un “fascista integrale, profondamente convinto della bontà” del sistema dittatoriale. Tuttavia era anche un conservatore. Agghindato “in frac e cilindro (ma preferibilmente in abito da sera), [era] costituzionalmente ostile per educazione e classe agli atteggiamenti e ai comportamenti sanguinari, rozzi, tronfi e inutilmente violenti”, tipici dei fascisti di rango minore (p. 64). Non sorprende che questo “genero del regime”, come lo definisce forse fin troppo spesso Di Rienzo, non sia stato mai popolare tra i suoi compagni di partito, ma per lo più invidiato. Paradossalmente, la sua versione elitaria della socialità impedì a Ciano di andare lontano in quelle che Di Rienzo mostra come le sue sporadiche ambizioni di scalzare Mussolini e sostituirlo al vertice della dittatura.
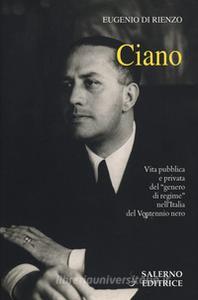 Si tratta dunque di un’opera importante, che merita la traduzione in inglese. Presenta tuttavia alcune asperità. La biografia conosce il meglio nelle prime centoventi pagine, in cui Di Rienzo indaga con chiarezza il contesto familiare di Ciano, e in particolare la carriera del padre Costanzo, ammiraglio nobilitato al rango di conte di Cortellazzo e Buccari, ininterrottamente ministro delle Comunicazioni dalla nomina, nell’aprile 1924, fino alla morte, avvenuta nel giugno 1939. In quel periodo, attraverso i contatti con l’industria e le banche, i Ciano si spostarono dalle loro origini relativamente modeste al rango di una delle dieci famiglie più facoltose del paese. I fratelli di Costanzo, Arturo e Alessandro, facevano da prestanome. In sostanza i Ciano furono un esempio di come le antiche tradizioni della famiglia italiana non furono affatto contenute dalle chiacchiere fasciste sul totalitarismo. Incidentalmente Di Rienzo inoltre che a Galeazzo (nato nel 1903) fu concessa l’appartenenza retroattiva alla terribile squadra toscana La Disperata; doveva provare di essere stato fascista dai primi giorni del movimento e dunque un marito adatto per Edda Mussolini.
Si tratta dunque di un’opera importante, che merita la traduzione in inglese. Presenta tuttavia alcune asperità. La biografia conosce il meglio nelle prime centoventi pagine, in cui Di Rienzo indaga con chiarezza il contesto familiare di Ciano, e in particolare la carriera del padre Costanzo, ammiraglio nobilitato al rango di conte di Cortellazzo e Buccari, ininterrottamente ministro delle Comunicazioni dalla nomina, nell’aprile 1924, fino alla morte, avvenuta nel giugno 1939. In quel periodo, attraverso i contatti con l’industria e le banche, i Ciano si spostarono dalle loro origini relativamente modeste al rango di una delle dieci famiglie più facoltose del paese. I fratelli di Costanzo, Arturo e Alessandro, facevano da prestanome. In sostanza i Ciano furono un esempio di come le antiche tradizioni della famiglia italiana non furono affatto contenute dalle chiacchiere fasciste sul totalitarismo. Incidentalmente Di Rienzo inoltre che a Galeazzo (nato nel 1903) fu concessa l’appartenenza retroattiva alla terribile squadra toscana La Disperata; doveva provare di essere stato fascista dai primi giorni del movimento e dunque un marito adatto per Edda Mussolini.
In effetti Galeazzo non fu uno squadrista bensì un brillante studente di legge, che sperava di fare colpo con una commedia dal titolo La felicità d’Amleto, messa in scena (“con un clamoroso insuccesso”, p. 72) al Teatro Argentina di Roma. Inoltre era piuttosto attivo sessualmente, ci assicura Di Rienzo in alcune pagine che avrebbero meritato un migliore apparato di note, non soltanto all’interno di quello che divenne il “matrimonio aperto” con Edda, ma in tutte le classi sociali. Tuttavia le sue partner predilette provenivano dal salotto aristocratico della principessa Isabella Colonna, dove paradossalmente poté sviluppare e mantenere ottimi contatti con il Vaticano.
Nei capitoli successivi Di Rienzo riduce le sue osservazioni sulla vita privata di Ciano e analizza le azioni di un giovane che, come apprendiamo, possedeva “una grande capacità di lavorare, una buona conoscenza delle lingue (tranne il tedesco), un ardito e pronunciato senso del compromesso, insieme all’inclinazione a considerare progetti e metodi ad ampio raggio” (p. 127). Promosso capo dell’Ufficio stampa e poi sottosegretario alla Stampa e alla propaganda (settembre 1934), Ciano si trasformò in una sorta di Goebbels italiano (che da un pezzo ammirava molto tra i nazisti) e si costruì con costanza una clientela tra i giornalisti e gli intellettuali della sua generazione.
Con l’insediamento di Ciano al Ministero degli Esteri, l’interesse principale di Di Rienzo ne diventa la politica, con una analisi un po’ scettica del celebre diario di Ciano, che, l’autore ne è convinto, costituisce in realtà una fonte debole riguardo alla “verità” di ciò che poteva accadere nell’Italia fascista. Di Rienzo si concentra dunque sulla tradizionale storia diplomatica, con un prevedibile accento sul fatto che sia Mussolini che “il genero” perseguivano obiettivi “già tracciati dalla politica estera italiana prima del 1922” (p. 189). A tale riguardo, il tentativo italiano di agire quale “quarta ruota” dell’Europa fu mandato in pezzi dalla “cieca ostinazione” di Anthony Eden (p. 203), il quale, nel 1935-36 rispetto all’Etiopia presagì il successivo disastro dell’Impero britannico in declino davanti alla crisi di Suez. E il libro arriva alla disastrosa guerra accanto a Hitler, al primo rovesciamento di Mussolini, il 25 luglio 1943, favorito dal “tradimento” del genero e alla morte di Ciano, avvenuta a Verona l’11 gennaio 1944 davanti a un vendicativo plotone d’esecuzione della Repubblica Sociale.
Di Rienzo fa poco per esaminare la scarsa reputazione di Ciano nel quadro politico dell’Italia repubblicana dopo il 1945. Tuttavia ci racconta che, paradossalmente, nel 1948 la Corte di Cassazione decretò che era stato iniquo sequestrare i beni della famiglia Ciano, dal momento che Galeazzo era stato un “martire della guerra di liberazione”. Nel nostro fallibile mondo di uomini, come afferma Di Rienzo nella citazione iniziale, a quanto pare “la verità non esiste, esistono solo le storie”.
(Traduzione di Massimiliano Manganelli)
(Pubblicato in © «English Historical Review», ceaa037, https://doi.org/10.1093/ehr/ceaa037)
