di Luigi Morrone
Senofonte, tra il V ed il IV sec. a.C., raccontò la guerra civile tra Ciro e Dario per il trono di Persia, e le imprese militari dello spartano Agesilao; Procopio di Cesarea ci ha lasciato il resoconto più completo della lunga e sanguinosa guerra gotica nel VI secolo d.C. Entrambi erano soldati che raccontarono le guerre a cui parteciparono.
Viceversa, il quarantenne ufficiale addetto al Comando Generale Gioacchino Volpe, quando si arruola, è già uno storico affermato, coinvolto da Prezzolini nella direzione di un progetto di ricostruzione della storia nazionale da pubblicare nelle edizioni della “La Voce”, progetto abortito per l’incombere della guerra. E, da grande storico qual è, redige non un “diario di guerra”, ma un’approfondita analisi delle operazioni belliche, dei suoi risvolti e delle sue implicazioni, articolatasi in tre volumi. Ora, nel centenario della Vittoria nella Grande Guerra, Rubettino ripubblica il saggio di Gioacchino Volpe, Da Caporetto a Vittorio Veneto, dedicato agli ultimi due anni di guerra, curato da Andrea Ungari.
Nel 1917 gli Imperi Centrali sembrano ormai avviati alla sconfitta, e l’intensificarsi delle offensive appaiono come mezzi per ottenere una “pace onorevole”, specie dopo la morte del vecchio Kaiser austriaco Franz Joseph e l’ascesa al trono del giovane Karl, pacifista per tendenza. Ma la guerra sottomarina, rovesciando la supremazia anglofrancese sui mari, porta lo scompiglio tra le fila dell’Intesa, che adotta una tattica attendistica, nella consapevolezza «che il tempo non era nemico ma alleato dell’Intesa», tanto più dopo l’entrata in guerra degli USA e l’attesa dell’organizzazione della sua poderosa macchina bellica. In questa fase, l’Italia non segue il temporeggiare degli alleati, e continua le sue offensive, per contrastare le quali, l’Austria chiama in ausilio le truppe tedesche, liberate sul fronte orientale dal crollo della coalizione serbo – russa.
Volpe analizza la situazione delle truppe italiane in quel 1917: orgoglio crescente, sforzo produttivo enorme dell’industria bellica, con conseguente progresso tecnologico dell’apparato militare. Ma, per converso, analizza i contraccolpi di una guerra di durata inusitata: «peggioramento nel vitto, nel vestiario, peggioramento nei rapporti fra Comandi e truppe, fra ufficiali e soldati». Il malcontento serpeggia. E Cadorna? «Tutto chiuso nel cerchio dei suoi pensieri e delle sue convinzioni morali, elementare nella sua concezione della disciplina, egli poco si guardava attorno, poco attingeva alla esperienza, poco alla comune umanità, sia pure per meglio controllarla e dominarla».
E la guerra, che era stata “guerra di popolo” con la vittoria della “piazza” interventista sulle istituzioni neutraliste, ora divideva tutti da tutti. Ed il protrarsi delle operazioni belliche aveva rinfocolato i vecchi neutralisti dai clericali ai liberal-conservatori, ai socialisti, che soffiano sul malcontento per fomentare manifestazioni di piazza, sulla giusta osservazione che la guerra stava arricchendo i “padroni” e sull’aire dei crescenti successi dei bolscevichi in Russia, che termineranno con la “rivoluzione d’ottobre”. Dall’altra parte, c’è chi incita alla prosecuzione di una guerra di riscatto di una nazione giovane, che cerca nel crogiolo bellico una unità che la pace non aveva saputo o voluto raggiungere e lotta contro il “disfattismo”, anche se – annota Volpe – il “disfattismo” è molto più presente nel “Paese” che non fra i combattenti, che pure non ne sono immuni.
L’invocato aiuto tedesco arriva, con le truppe del Kaiser fanatizzate da una stampa che dipinge un’Italia allo stremo e dilaniata dalle lacerazioni interne, e le forze austro tedesche scatenano una poderosa offensiva che mira ad occupare la pianura friulana e da lì dilagare lungo la pianura padana per minacciare la Francia da Est. Bombardamenti continui, anche con gas asfissianti, senza alcuna risposta d’artiglieria italiana. Scarsa anche la resistenza della fanteria. Volpe loda le poche formazioni italiane che si mostrano all’altezza dello scontro, in particolare la Brigata Etna e il battaglione Albergian deli Alpini. Gli italiani arretrano. A Caporetto, gli austro-tedeschi sfondano. Volpe si interroga sul perché non si riesce a sfruttare la superiorità numerica e individua la responsabilità: «alcuni Comandi, a cui il nemico si impose con una superiore strategia, una superiore tattica, una superiore organizzazione». Respinge, invece, le voci di “tradimento” che serpeggiano fin da subito.
Il disastro di Caporetto da fiato ai disfattisti. Alcuni tra le classi agiate meditano di lasciare l’Italia che ritengono perduta. I socialisti gridano al fallimento dell’Italia borghese. Nel frattempo, prosegue la ritirata italiana, che – secondo i disegni di Cadorna – si arresta al Piave, dove già da all’inizio del decennio erano state eseguite opere di fortificazione in vista di un eventuale conflitto con l’Austria: «il Piave era la classica linea di resistenza per l’esercito italiano, nel pensiero del suo Stato Maggiore. Saletta aveva stabilito su quel fiume lo schieramento, in caso di guerra con l’Austria. Pollio si era spinto sino al Tagliamento, costruendovi fortezze sui monti».
A far le spese del disastro di Caporetto è tuttavia il capo di Stato Maggiore Cadorna, dopo qualche giorno di interregno sostituito dal napoletano Diaz, del quale Volpe riconosce una maggiore capacità di gestione del rapporto umano con i soldati, rispetto al suo predecessore, pur riconoscendo a questi la capacità di avere evitato la rotta dopo la sconfitta. Volpe giustifica comunque la scelta del “capro espiatorio” per ragioni psicologiche: in quel momento, Cadorna rappresenta Caporetto, rappresenta la sconfitta, non la ritirata strategica.
Con il comando interalleato si decide la resistenza alla penetrazione nemica sulla linea Monte Grappa – Piave, ma gli alleati non supportano in modo massiccio l’operazione, preferendo schierare le truppe anglofrancesi a difesa dell’eventuale espansione ad Ovest degli Austro-tedeschi. Una questione tutta italiana, dunque.
E la resistenza sulla linea Piave-Montegrappa, dopo un primo sbandamento, ha successo, supportata da un consenso popolare probabilmente imprevisto, tanto che «Disertori e renitenti si sentirono, da questo nuovo sentimento pubblico che aleggiò attorno ad essi, spinti a presentarsi ai Corpi a chiedere di essere mandati al fronte». La classe 99, già chiamata alle armi durante quel 1917, risponde con entusiasmo all’invio in prima linea. Non solo il disfattismo non fa breccia nelle truppe, per quanto tra i fanti serpeggi il disprezzo verso i “signori” che “se la scialano” evitando i disagi ed i pericoli della guerra. Anche le Istituzioni si muovono. Viene creata l’Opera Nazionale Combattenti, per supportare logisticamente ed economicamente i combattenti al ritorno dal fronte.
L’entusiasmo ed il valore militare dei soldati italiani, coscienti di avere da soli reagito ad una dura sconfitta, fa rapidamente riguadagnare all’Esercito italiano le posizioni perse nella grande offensiva nemica dell’autunno 1917 già nel gennaio 1918. In dieci mesi, le forze nemiche sono debellate «L’Italia, dopo essersi quasi ravvisata in Caporetto, ha ritrovato il Piave e Vittorio Veneto, cioè la coscienza della Vittoria»
Il volume è preceduto da Caporetto come problema storiografico, saggio introduttivo di Eugenio Di Rienzo, profondo conoscitore dell’opera di Gioacchino Volpe (autore di una biografia dello storico edita da Le Lettere di Firenze e della omonima voce apparsa ne Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Storia e Politica, edito dalla Treccani), nonché autore e curatore del numero monografico di “Nuova Rivista Storica” (L’Italia e il primo conflitto globale, 1915-1918). Di Rienzo analizza sul piano storiografico la battaglia di Caporetto, ridimensionando la portata della sconfitta italiana, amplificata dalla memoria popolare: le nostre pur importanti perdite, nei fatti, inferiori a quelle riportate dagli Alleati nella prima battaglia della Marna o dagli austro-ungarici in Galizia, le leggende sul presunto “sciopero militare”, in realtà inesistente o sulla marea di diserzioni, di non ampia rilevanza, se rapportate ad altre analoghe situazioni verificatesi su altri fronti nel corso del conflitto.
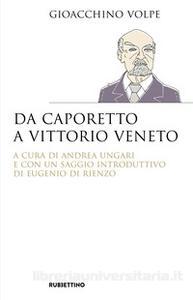 L’amplificazione della portata della sconfitta è attribuita da Di Rienzo alla propaganda che tendeva a presentare la sconfitta come una sorta di “rivoluzione proletaria” simile alle defezioni verificatasi nelle armate russe ad opera dei bolscevichi. Di Rienzo, come già Gioacchino Volpe, stigmatizza chi amplifica le colpe di Cadorna, dimenticando l’abilità del Comandante Supremo nell’impedire la rotta e nel gestire la ritirata, prodromo di quelle che poi sarà la riscossa fino a Vittorio Veneto. La sconfitta, secondo Di Rienzo, che si rifà anche a studi militari stranieri, è da attribuire sì a deficienze tattiche di “alcuni comandi” (come già per Gioacchino Volpe), ma soprattutto all’inedita tattica utilizzata dal nemico, con rapide incursioni al di là delle linee, anziché insistere nel logoramento di trincea. E, quanto a individuare chi siano gli “alcuni comandi” responsabili degli errori tattici, Di Rienzo non ha difficoltà ad indicare Capello e Badoglio, soprattutto quest’ultimo, che lascia sguarnita la linea di Caporetto che tutte le informazioni militari indicavano quale direttiva dell’avanzata nemica. Secondo gli approdi storiografici ricordati da Di Rienzo, sul piano militare, è quello l’errore fatale che portò allo sfondamento delle linee italiane da parte degli Imperi Centrali.
L’amplificazione della portata della sconfitta è attribuita da Di Rienzo alla propaganda che tendeva a presentare la sconfitta come una sorta di “rivoluzione proletaria” simile alle defezioni verificatasi nelle armate russe ad opera dei bolscevichi. Di Rienzo, come già Gioacchino Volpe, stigmatizza chi amplifica le colpe di Cadorna, dimenticando l’abilità del Comandante Supremo nell’impedire la rotta e nel gestire la ritirata, prodromo di quelle che poi sarà la riscossa fino a Vittorio Veneto. La sconfitta, secondo Di Rienzo, che si rifà anche a studi militari stranieri, è da attribuire sì a deficienze tattiche di “alcuni comandi” (come già per Gioacchino Volpe), ma soprattutto all’inedita tattica utilizzata dal nemico, con rapide incursioni al di là delle linee, anziché insistere nel logoramento di trincea. E, quanto a individuare chi siano gli “alcuni comandi” responsabili degli errori tattici, Di Rienzo non ha difficoltà ad indicare Capello e Badoglio, soprattutto quest’ultimo, che lascia sguarnita la linea di Caporetto che tutte le informazioni militari indicavano quale direttiva dell’avanzata nemica. Secondo gli approdi storiografici ricordati da Di Rienzo, sul piano militare, è quello l’errore fatale che portò allo sfondamento delle linee italiane da parte degli Imperi Centrali.
Ma il saggio di Di Rienzo è essenzialmente mirato all’analisi del “problema storiografico” di una disfatta che non è solo militare, ma è conseguenza di fattori più ampi, involgenti l’intera popolazione. Di Rienzo inoltre propone un’analisi delle difficoltà di Volpe a potere studiare approfonditamente gli archivi per una ricostruzione compiuta della Grande Guerra italiana, difficoltà essenzialmente legate al fatto che il grande storico aderisce, sì al fascismo, senza mai allinearsi, però, a tutti i dogmi del regime.
(Pubblicato il 27 dicembre 2018 – © «Quotidiano del Sud»)
